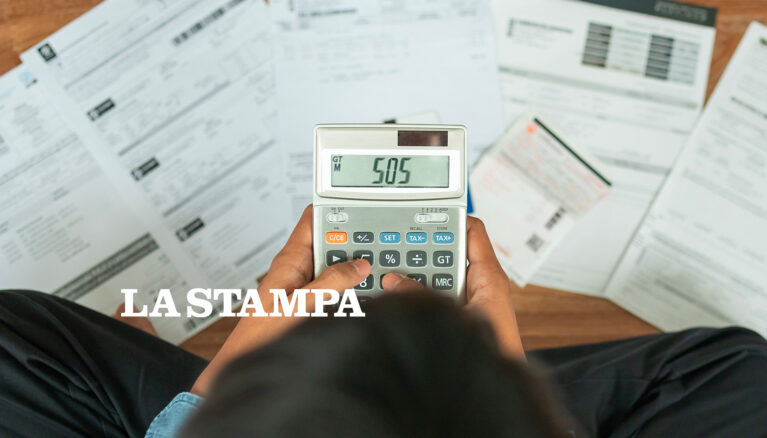Intervista ad Agostino Re Rebaudengo, Presidente ASJA ENERGY Società Benefit
Condivido con i lettori del blog la mia intervista sull'edizione di aprile di natura e società.
- Come cambia il panorama energetico mondiale dopo la sterzata fossile di Trump?
Donald Trump potrà rallentare la transizione energetica, ma non fermarla. Come osserva Bloomberg New Energy Finance, i progressi tecnologici, i piani di sviluppo delle imprese e le forze di mercato continuano a dare slancio alla transizione, e gli investimenti in energia pulita e nuove tecnologie per il clima aumenteranno costantemente.
Secondo l’International Renewable Energy Agengy (IRENA), il 2024 è stato un anno record per le energie rinnovabili: oltre il 90% della nuova capacità di energia installata a livello mondiale è stata rinnovabile, una tendenza in continua crescita ormai da anni (nel 2022 è stata rinnovabile oltre l'80% di nuova potenza elettrica realizzata).
Un trend così netto e consolidato è altamente improbabile che si arresti, anche considerando la crescente competitività economica delle tecnologie energetiche rinnovabili.
Resta vero che con Trump non è il migliore dei momenti per la transizione energetica, come credo di certo non lo sia per l’intera economia mondiale.
Ad una situazione geopolitica già gravemente instabile, gli scossoni di Trump hanno aggiunto forte instabilità anche a livello economico, seguendo una logica che appare davvero difficile comprendere. In antitesi con il suo mantra, Make America Great Again, le scelte di Trump potrebbero danneggiare l’economia americana che tanto vorrebbe tutelare. Secondo il Wall Street Journal, la politica dei dazi di Trump potrebbe tradursi in un aumento della spesa per i cittadini americani di circa 150 miliardi di dollari all'anno (pari alla stima dei dazi dell’ammontare dei dazi incassati dal Governo). Ad esempio, un americano potrebbe dover spendere circa 10.000 dollari in più per acquistare un’automobile di fascia media, anche se assemblata in America. È il risultato dei dazi voluti da Trump per favorire l’industria americana dell’automotive e scoraggiare le importazioni di auto.
Il punto è che Trump non ha fatto i conti con la globalizzazione. A ricordagli le conseguenze nefaste dei dazi sulle auto e i loro componenti importati, è stato persino l’uomo a lui più vicino, Elon Musk che su X ha scritto che i dazi avranno un impatto significativo sui costi di produzione delle Tesla, facendo lievitare il prezzo dei pezzi di ricambio importati.
Che piaccia o no a Trump, chi fa impresa oggi compete in un mercato globale, fatto di continui scambi. Un prodotto realizzato dentro i confini americani impiega materie prime e semilavorati importati, che quindi diventerebbero più cari, e viceversa, ovvero, prodotti realizzati all’estero possono avere un’altissima percentuale di componenti Made in USA.
- Come è cambiato il panorama energetico italiano con l'attuale governo?
Per alcuni aspetti, la situazione energetica del nostro Paese non è cambiata molto negli ultimi 3 anni. L’Italia continua ad essere il Paese europeo con la maggiore dipendenza energetica dalle importazioni dall’estero di combustibili fossili, principalmente gas.
Nel 2024, importare gas ci è costato 1 punto di PIL, il nostro Paese ha speso 22,4 miliardi di euro. Nel 2023 per importare gas abbiamo speso 28,3 miliardi di euro. In Italia, nel 2022, la spesa per le importazioni di gas naturale è stata di 85,4 miliardi di euro rispetto ai 12,4 miliardi del 2019.
L’alto prezzo del gas e la sua variabilità incidono notevolmente sia sulla sicurezza economica ed energetica dell’Italia, sia sul prezzo dell’energia elettrica perché per produrre la maggior parte dell’elettricità viene utilizzato ancora il gas.
Proprio per aumentare la sicurezza e l’indipendenza energetica, e anche a beneficio della stabilità economica dell’Italia, 3 anni fa, il giorno dopo lo scoppio della guerra della Russia contro l’Ucraina, ho presentato insieme alle maggiori imprese elettriche italiane una roadmap per installare 20 GW di rinnovabili all’anno per 3 anni, prevalentemente con impianti di grande taglia (così da tagliare le importazioni di gas e ridurre i costi dell’energia elettrica).
Sono trascorsi 3 anni, e invece di 60 GW abbiamo realizzato solo poco più di 16 GW, peraltro prevalentemente impianti di piccola taglia, il cui kWh costa fino a 3 volte di più rispetto a un grande impianto.
Per un raffronto, la Germania in un solo anno, il 2024, ha installato 20 GW di energia rinnovabile. L’Italia per installare 20 GW ci ha messo 7 anni.
Quello che è cambiato, peggiorando, nel panorama della transizione energetica dell’Italia è il quadro normativo. I positivi interventi di semplificazione avviati dal Legislatore sono stati vanificati da una serie di recenti provvedimenti il cui combinato disposto rende quasi irrealizzabili i nuovi impianti e fa aumentare i costi dei pochi che si riescono a realizzare.
- Come si concilia la transizione ecologica con la tutela del territorio e del paesaggio (fv a terra, eolico sui crinali ...)
Più che conciliarsi, è bene ricordare che la transizione ecologica è l’unica possibilità per tutelare il territorio e il paesaggio dalle conseguenze del cambiamento climatico.
Per ridurre le emissioni di CO2 come dovremmo, è necessario anche decarbonizzare l’energia elettrica. E farlo, significa installare impianti rinnovabili.
Per raggiungere gli obiettivi clima-energia al 2030 che l’Italia ha sottoscritto, servirebbe solo lo 0,2% del territorio italiano, quindi, non è vero che bisognerebbe tappezzare l’Italia di pale e pannelli!
Come non è vero che verrebbero sottratti terreni all’agricoltura. Solo per fare un’ipotesi, se tutti gli impianti rinnovabili necessari per i target 2030 venissero realizzati in aree agricole, significherebbe utilizzare solo lo 0,4% (70 mila ettari) della Superficie Agricola Totale (SAT), una porzione marginale anche se paragonata ai 4 milioni di ettari di terreni agricoli abbandonati.
La civiltà umana ha sempre modificato il paesaggio, e l’evoluzione della nostra Cultura è andata di pari passo con la trasformazione dei territori. Sarebbe incredibile che per volerli tutelare li lasciassimo tutti soccombere al cambiamento climatico.
- Come si impegnano ASJA ENERGY e ARR per la transizione energetica e la tutela dell'ambiente?
Contribuire a rendere più sostenibile la nostra permanenza sul Pianeta è un denominatore comune a tutte le mie attività, dalla mia impresa all’insegnamento, dalla vita associativa all’impegno per diffondere l’educazione ambientale, dalle energie che investo nel mondo dell’arte a quelle che metto per il restauro, la cura e la conservazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico.
Ho fondato ASJA ENERGY, che oggi è diventata una Società Benefit, nel 1995, ancor prima della firma del Protocollo di Kyoto. In quegli anni, la sostenibilità ambientale e la transizione energetica erano concetti rivoluzionari, lontanissimi dagli orizzonti di certezza che solitamente si prediligono nelle scelte imprenditoriali. Ho corso un rischio, ma sentivo di fare la cosa giusta ad avventurarmi da pioniere su questa strada, e a creare un’impresa che quest’anno compie 30 anni e progetta, costruisce e gestisce impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile (da biogas, vento e sole) e di biometano, riducendo le emissioni di CO2.
Sono docente all'Università Campus Bio-medico di Roma con un corso sull'economia circolare in cui insegno agli studenti anche a comprendere il cambiamento climatico, le sue cause, conseguenze e soluzioni.
Negli ultimi 14 anni, prima alla guida di assoRinnovabili (la maggiore associazione italiana di produttori di energia da fonti rinnovabili), e poi, fino allo scorso dicembre, come presidente di Elettricità Futura (la principale Associazione del settore elettrico italiano di cui sono oggi past president), ho sempre lavorato per rimuovere gli ostacoli al raggiungimento della sostenibilità energetica in Italia.
Con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, di cui sono co-fondatore e vice presidente, abbiamo realizzato il Parco d’Arte sulla collina di San Licerio a Guarene che è stato inserito dal prestigioso quotidiano britannico The Guardian tra i migliori 10 Parchi all’aperto d’Europa. L’innovativo progetto della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è un perfetto connubio tra natura, arte e sostenibilità nello straordinario paesaggio di Langhe e Roero, Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Insieme al Parco d’Arte, è stato anche realizzato sulla collina un progetto di piantumazione che ha consentito la messa in sicurezza del Parco e la tutela della biodiversità.
Sono fondatore e consigliere della Venice Gardens Foundation, che dal 2014 è impegnata nel restauro e nella conservazione di parchi e giardini e beni di interesse storico e culturale. Tra i progetti della Fondazione vi è il restauro e la riapertura al pubblico dei Giardini Reali di San Marco, e il restauro del Compendio del Giardino - l’Orto, le Cappelle di meditazione, le Antiche Officine e la Serra - del Convento della Chiesa palladiana del Santissimo Redentore, luogo di alto valore storico, simbolico e spirituale che è stato riaperto al pubblico lo scorso ottobre.
- Come si sta sviluppando il progetto di ASJA ENERGY sull'area Bonafous adiacente all’area ex Thyssen, in relazione alle necessarie bonifiche e agli sviluppi futuri?
Con una visione simile alle iniziative appena descritte a Venezia, ho avviato il recupero di un’importante area vicina al Parco della Pellerina che è rimasta in stato di abbandono per oltre trent’anni. Abbiamo proposto alla Città di Torino un progetto di riqualificazione sostenibile dell’area Bonafous. Nel rispetto del Piano Regolatore, intendiamo valorizzare l’identità industriale del luogo e promuovere la nascita di un innovativo datacenter.
Il datacenter di ASJA, grazie alla sua esperienza trentennale nella realizzazione di progetti complessi e sostenibili, sarà alimentato dai nostri impianti per la produzione di elettricità rinnovabile. La costruzione del datacenter, oltre a rispettare i massimi standard di efficienza, aprirà alla simbiosi industriale nel pieno rispetto della circolarità e sostenibilità. Infatti, stiamo lavorando affinché il calore che verrà prodotto dal datacenter possa essere riutilizzato nella rete di teleriscaldamento.
Stiamo lavorando insieme alla Città di Torino per realizzare questo progetto di riqualificazione in tempi brevi e nel pieno rispetto dell’ambiente, rilanciando la crescita della nostra Città senza consumo di nuovo suolo.
Entro la fine del 2025, nell’area Bonafous, acquistata solo 1 anno fa, completeremo la demolizione e la rimozione delle strutture esistenti e dei materiali contenenti amianto, e le bonifiche.
Questa intervista è stata pubblicata su natura e società edizione di aprile 2025.